| Il complesso architettonico di S. Filippo Apostolo - di Valeria Falsaperla | |
| Notizie storiche sugli ipogei di Ortigia - di Michele Romano | |
| Il complesso architettonico di S. Filippo Apostolo - di Valeria Falsaperla | |
| Notizie storiche sugli ipogei di Ortigia - di Michele Romano | |
Il complesso di S. Filippo Apostolo è situato ad Ortigia nel quartiere della Giudecca. E' costituito da un insieme di architetture ed ambienti posti su diversi livelli, ovvero la chiesa e gli spazi sotterranei: la cripta dipinta, le latomie ed il pozzo ebraico. E' possibile accedere a tali spazi sotterranei attraverso una apertura nel pavimento della chiesa.
 Il
prospetto principale della chiesa di S. Filippo apostolo si
affaccia sulla piazza omonima, caratterizzata dalla presenza di
due obelischi piramidali.
Il
prospetto principale della chiesa di S. Filippo apostolo si
affaccia sulla piazza omonima, caratterizzata dalla presenza di
due obelischi piramidali.
L'organismo è a pianta longitudinale, privo di transetto e con
abside semicircolare tipicamente posta a conclusione
dell'impianto monodirezionato.
Presenta un interno a tre navate, divise da pilastri poligonali,
cui sono accostate colonne poste a sostegno di archi a tutto
sesto. L'interno è interamente ornato da un apparato decorativo
settecentesco. L'abside semicircolare accoglie l'altare maggiore
ed è affiancata sui due lati, rispettivamente, da una cappella e
dalla sagrestia.
 L'abside
è sormontata da una volta a catino, le campate mediane delle
navate laterali presentano soffitti con finte volte a botte,
mentre le altre quattro campate laterali sono voltate a cupola su
pianta ellittica avente l'asse maggiore parallelo all'asse
longitudinale della chiesa. L'ampia campata mediana della navata
centrale è sormontata da pennacchi sferici a sostegno del
tamburo sul quale si impostava la cupola emisferica oggi
mancante.
L'abside
è sormontata da una volta a catino, le campate mediane delle
navate laterali presentano soffitti con finte volte a botte,
mentre le altre quattro campate laterali sono voltate a cupola su
pianta ellittica avente l'asse maggiore parallelo all'asse
longitudinale della chiesa. L'ampia campata mediana della navata
centrale è sormontata da pennacchi sferici a sostegno del
tamburo sul quale si impostava la cupola emisferica oggi
mancante.
Il corridoio rettilineo, attraverso il quale si accede alla cripta, si compone di due tratti: il primo con soffitto piano e il secondo, di poco più ampio, con soffitto voltato a botte. La cripta, posta ad una quota di poco inferiore rispetto a tale corridoio, è a pianta longitudinale e simmetrica e presenta una copertura voltata a botte. Si sviluppa su due livelli. La zona superiore presenta lateralmente e simmetricamente due aperture che danno accesso ciascuna ad un piccolo vano rettangolare chiuso superiormente da una volta a botte.
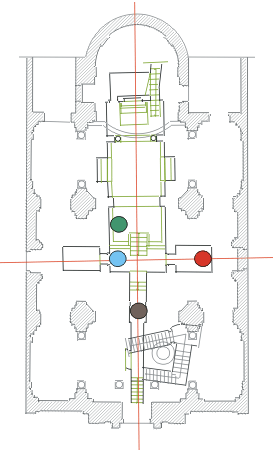 Legenda della
planimetria della Chiesa e della cripta sottostante (in verde):
Legenda della
planimetria della Chiesa e della cripta sottostante (in verde):
![]() Stazioni
della Via Crucis,
Stazioni
della Via Crucis, ![]() Teschio con cartiglio,
Teschio con cartiglio, ![]() Croce prospettica,
Croce prospettica, ![]() Scheletro.
Scheletro.
Il livello superiore è delimitato da due balaustrate situate
simmetricamente rispetto all'asse longitudinale della cripta, in
corrispondenza del quale è posta una scala che collega i livelli
superiore ed inferiore.
Quest'ultimo spazio è ritmato dalla due archi a tutto sesto, uno
impostato su lesene e l'altro sorretto da colonne a fusto liscio
ed entasis pronunciata con capitello dorico. La zona antistante
quest'ultimo arco, probabilmente utilizzata come luogo di
riunione e di culto, oltre che di sepoltura, presenta lungo gran
parte del perimetro resti di sedili in muratura poggianti su
balaustrini, mentre lateralmente e simmetricamente vi sono due
altari incassati in nicchie delimitate superiormente da archi a
tutto sesto. Nello spazio oltre l'arco su colonne, anch'esso con
soffitto voltato a botte, ed in posizione assiale è collocato un
altare, al di sopra del quale si trova una ampia nicchia di forma
rettangolare.
A destra dell'altare una scala in pietra ad andamento rettilineo
conduce ad un vano, posto ad un livello ancora inferiore, scavato
nella viva roccia e delimitato da pareti ad andamento irregolare
e curvilineo.
A sinistra dell'altare una piccola apertura consente l'accesso ad
un vano di forma grosso modo rettangolare, che si apre sul vano
della scala ora descritta.
E' interessante notare la corrispondenza planimetrica esistente
tra l'impianto della chiesa e quello della cripta sotterranea.
Entrambe, infatti, sono organismi a pianta longitudinale e si
sviluppano lungo la stessa direzione; lungo lo stesso asse,
ortogonale a questa direzione, sono posti, a livello della
chiesa, i due ingressi laterali e, a livello della cripta, i due
vani rettangolari sopra descritti; esiste anche una
corrispondneza tra la posizione degli altari della prima campata
delle navate laterali della chiesa e quelli della cripta, posti
grosso modo sullo stesso asse; sono quasi coincidenti le
posizioni degli altari maggiori della chiesa e della cripta; ed,
infine, una ulteriore evidente corrispondenza è riscontrabile
tra l'arcata di raccordo trasversale tra i pilastri poligonali
della chiesa e l'arco a tutto sesto della zona inferiore della
cripta.
La cripta è in gran parte decorata con affreschi, oggi in
precario stato di conservazione. Tali affreschi sono visibili, in
particolare, in corrispondenza delle pareti laterali del tratto
più ampio del corridoio, al di sopra dell'architrave delle
aperture che consentono l'accesso ai vani laterali, su una parete
all'interno dei vani stessi, al di sopra del cornicione che
percorre l'intero perimetro della zona inferiore della cripta e
in parte delle pareti della stessa zona, sul fondo della nicchia
posta al di sopra dell'altare.
Arch. Valeria Falsaperla
La simbologia escatologica degli affreschi ipogei di San
Filippo apostolo è un chiaro riferimento alla caducità della
vita e alla transitorietà dei beni terreni. Nel lungo corridoio
di entrata due ameni scheletri invitano
alla sala della "trasmutazione", alla cripta dipinta
dove gli esercizi spirituali controriformati guidano alla
solennizzazione e ineluttabilità della morte, alla "humana
fragilitas".
La raffigurazione di due ironici teschi-sovrapporta
indica il "memento mori" ammonendo il fedele con
l'allegorico motto: "FUIMUS SICUT E VOS - ERITIS SICUT E
NOS" (fummo così come voi - sarete così come noi).
 Sono forse i veri
significati reconditi della vita cristiana, i temi della
"vanitas" umana, la caducità della vita, un percorso
che riscopre i temi della "passio" divina e
dell'Apocalisse.
Sono forse i veri
significati reconditi della vita cristiana, i temi della
"vanitas" umana, la caducità della vita, un percorso
che riscopre i temi della "passio" divina e
dell'Apocalisse.
Non a caso questo ciclo di affreschi si completa con una sequenza
di momenti della Via Crucis, cappelle
laterali con la prospettica croce sul
Calvario e una decorazione macabra di teschi che si completano
sull'altare con la raffigurazione del Cristo morto.
L'escatologia cristiana sulla morte ed il giudizio universale si
conferma nel ciclo figurativo di questo ipogeo aretuseo con lo
schema iconologico tipico delle cappelle funerarie, tombe e
sarcofagi, dove l' "ars moriendi" e il "trionfo
dela morte" suscitano e confermano il timore dell'ultima
ora, mentre le "macabre danze" e lo scheletro dalle
pose viventi rievocano la specularità della vita.
"Minuta polve e fragil vetro io sono" è il motto di
Saturno che, con l'orologio del tempo e la scheletricità umana
ricorda l'eguaglianza degli esseri davanti alla morte, come grave
e pressante avvertimento.
Il Masaccio fiorentino nella "Trinità" di Santa Maria
Novella raffigura uno scheletro con le allegoriche parole:
"IO.FUI.GIA.QUEL.CHE.VOI.SIETE: E QUEL.CHI SON VOI.ANCOR.
SARETE". Un evidente richiamo al dogma e al mistero della
morte che si rivela all'uomo attraverso la sofferenza, la
crocifissione e la passione di Cristo che lo riscatta dalla fine
eterna.
Questo itinerario sotterraneo e celeste, questo percorso
nell'iconografia e iconologia della vita, rievoca ironicamente,
con intenti didascalici e moralizzatori, l'impotenza degli uomini
di fronte alla morte. Un ciclo vitale e orrifico dove l'immagine
o la posa di uno scheletro nella sua grottesca quotidianità
induce il fedele osservatore al "trionfo della morte",
al teatro della "vanità", all'idea della vita come
apparato effimero, quasi una esasperazione della fedele angoscia
per il proprio destino. La "VANITAS VANITATUM OMNIA
VANITAS" (vanità delle vanità, tutto è vanità) che il
ceroplasta siracusano Gaetano Giulio Zumbo riuscì ad esprimere
con epidemie e pestilenze in cui mostra scheletri dalla sfumatura
di terracotta (ma sono di cera) e accanto cadaveri distesi su
cenotafi di marmo bianco.
Nel Seicento il misticismo e l'allegoria della vanitas si
inserirono nel dubbio della caducità ed eternità, la vanità
come apoteosi mondana e l'orrifica morte come transitorietà
della vita.
Lo spirito iconografico dell'asceta dal medioevo al barocco si è
soffermato volentieri sulla polvere e cenere e fino all'ottocento
le tombe mostrano la figura del cadavere, simbolo di ripugnanza
per l'aspetto terreno della morte. Paura di vivere, il rifiuto
della bellezza e della felicità, in quanto legate a calamità e
dolore.
Alla dissoluzione del corpo terreno si contrappone la
incorruttibilità delle spoglie ecclesiali (santi - martiri -
vescovi) mentre lo spirito materialistico non abbandona l'idea
del corpo. Il nostro ciclo iconografico persegue ambedue gli
aspetti, dall'ironica posa di scheletri pensanti e scriventi ad
un percorso mistico dove la "passio" divina incide
nella corruzione dell'anima terrena.
Un ipogeo cromatico e simbolico invita la comunità urbana alla
ricerca iconologica del sito, alla lettura dei temi escatologici,
alla relazione tra anima e corpo, una soluzione infinita del suo
divenire.
Prof. Michele Romano
Torna alla Home Page