I seguenti brani sono una sintesi di alcuni dei contributi al catalogo "Ortigia Sotterranea":
| Il progetto "Ortigia Sotterranea" - di Valeria Falsaperla | |
| Le fasi dell'attività di ricerca - di Enrico Costa | |
| Orientamenti di metodo e criteri di indagine - di Ettore Sessa | |
| Ortigia e l'acqua: aspetti geologici - di Antonello Mamo | |
| Segue una planimetria di Ortigia con individuazione dei siti ipogei. |
Il progetto "Ortigia Sotterranea" si colloca nel quadro degli interventi tesi a promuovere la conoscenza e la valorizzazione di beni e/o siti che rappresentino "testimonianza materiale avente il valore di civiltà", che siano, in altre parole, tracce a partire dalle quali sia possibile ricostruire il senso dei luoghi che tali "tracce" contengono.
Il progetto "Ortigia Sotterranea" individua come
centrali i concetti di identità dei luoghi e di diritto
all'eredità culturale e mira, pertanto, all'individuazione
di siti, elementi, beni utili alla ricostruzione/costruzione del
senso dei luoghi di Ortigia.
Si vuole, inoltre, dare risposta alla emergente domanda di consumo
attivo espressa da un pubblico che vuole acquisire
consapevolezza della propria storia, della propria identità e
che cerca un contatto diretto con il bene culturale che di tale
passato è testimonianza.
Si tratta, in altre parole, di soddisfare un'esigenza forte
dell'uomo di salvaguardare i siti o raccogliere ed esporre gli
oggetti rappresentativi dei valori della propria civiltà per
tramandare la propria eredità artistica e culturale, la propria
identità, appunto.
Si ritiene, ancora, che la tutela non possa limitarsi alla sola
conservazione fisica del bene, ma che piuttosto debba, in primo
luogo, riguardare i messaggi culturali che sono a monte
della realizzazione dei segni materiali; è essenziale, cioè,
valorizzare, prima dei beni culturali, il processo storico che li
ha generati, reinterpretando i rapporti con i contesti attuali.
In tal senso con il termine valorizzazione si deve
intendere il mantenimento della leggibilità dei rapporti
intercorrenti tra bene culturale e contesto territoriale nel
quale esso è inserito.
Un ulteriore aspetto che si vuole qui sottolineare riguarda
l'enfasi sempre maggiore che negli ultimi anni il concetto di utilità
sociale dei beni culturali legata alla loro fruizione è
andata acquistando. La nuova forte domanda di cultura ha,
infatti, segnato il passaggio dal bene considerato come oggetto
di tutela al bene come possibile motore di un nuovo sviluppo
economico ed occupazionale. E' evidente, però, che ad un
progetto culturale, quale è il progetto "Ortigia
Sotterranea", spetta il compito essenziale di rendere la
fruizione culturale non solo "consistente", ma anche consapevole.
Il progetto è stato ispirato da due principi fondamentali:
1. il principio di cooperazione interdisciplinare.
2. il principio di cooperazione internazionale.
In primo luogo l'applicazione del principio di cooperazione
interdisciplinare ha determinato la formazione del gruppo di
lavoro responsabile del progetto "Ortigia Sotterranea",
gruppo composto da studiosi aventi diverse specializzazioni e le
cui conoscenze sono state ritenute essenziali per il successo
della attività proposta.
In secondo luogo, condividendo pienamente il principio di
cooperazione internazionale, il progetto "Ortigia
Sotterranea" prevede la costruzione, a cura di chi scrive,
di una rete europea di cooperazione finalizzata allo
studio, alla salvaguardia ed alla valorizzazione di siti simili,
per contesto storico, tipologia, funzioni e tecniche costruttive,
ai siti ipogei presenti nell'isola di Ortigia, e che favorisca
l'arricchimento reciproco delle conoscenze e delle modalità di
intervento oltre che la valorizzazione della dimensione europea
dei beni in questione. E' indubbiamente questo uno tra gli
obiettivi principali e maggiormente innovativi del progetto di
"Ortigia sotterranea".
Un efficace strumento di divulgazione delle conoscenze acquisite
attraverso la ricerca che si sta conducendo è rappresentato da
questo sito web, pensato e progettato da chi scrive.
L'obiettivo è, dunque, quello di realizzare, accanto alle
numerose già esistenti, una nuova agorà elettronica,
un nuovo luogo di incontro e di scambio, di approfondimento e di
crescita culturale.
Arch. Valeria Falsaperla
L'attività di ricerca è stata articolata in due fasi.
La prima fase si è conclusa il 12 dicembre 1998 con una
conferenza sul tema.
L'incontro di dicembre ha consentito di mettere a fuoco tema ed
"oggetti" della ricerca, aprendo uno squarcio sulla
realtà sotterranea di Ortigia ed avviando così i cittadini
siracusani e non, la comunità scientifica nazionale ed
internazionale verso un nuovo percorso di conoscenza. Durante il
convegno, con il supporto di un primo catalogo, una ripresa
video e di pannelli illustrativi sono
stati presentati i diversi siti oggetto della ricerca, descritte
per grandi linee le caratteristiche, lo stato di conservazione e
le condizioni di accessibilità. In particolare sono stati
comunicati i primi, parziali, risultati della ricerca condotta
sul complesso architettonico di S.
Filippo Apostolo, un sito che si è pensato di presentare
già in questa prima fase in quanto costituito da un articolato
sistema di spazi ipogei. Tra questi vi è, in particolare, una
interessante cripta dipinta,
del tutto sconosciuta ai più, della quale fino ad oggi non
risultavano essere mai stati pubblicati né immagini
fotografiche, né tantomeno rilievi architettonici.
La seconda fase del progetto "Ortigia
Sotterranea" si concluderà in primavera. Gli esiti della
ricerca verranno illustrati in un catalogo che conterrà i
risultati della ricerca storica condotta sulle strutture
ipogee già individuate nella prima fase, le relative schede
di catalogazione e restituzioni grafiche dei
rilievi architettonici.
Questo sito, attivo dalla data della conferenza di dicembre,
verrà arricchito con nuove informazioni ed immagini messe a
disposizione di operatori scientifici e non interessati allo
studio di architetture ipogee.
Sarà, inoltre, messo a disposizione di studiosi ed appassionati
un archivio fotografico, organizzato per documentare in
maniera dettagliata le caratteristiche delle diverse strutture
ipogee.
Ed infine verrà presentato un progetto di recupero e
fruizione per rendere possibile
l'accessibilità/visitabilità dei diversi siti e, dunque, la
loro fruizione culturale e turistica.
Prof. Enrico Costa
Il programma della ricerca prevede una articolazione in tre
fasi principali (con denominazioni convenzionali), ognuna con
ulteriori sottosistemi di conoscenza o di elaborazione.
La prima fase, denominata indagine, è
incentrata sulla acquisizione scientifica, o sulla verifica, di
elementi e dati atti a quantificare, localizzare, distinguere e
periodizzare i "luoghi" oggetto della ricerca su
Ortigia ipogeica (anche nella eventuale successione delle
trasformazioni dei singoli esempi allo stato attuale delle
conoscenze). La fase di indagine comprende tre sottosistemi di
ricerca: inventario ricerche, censimento e iconografia storica.
La seconda fase, denominata analisi,
prevede la comprensione, tramite osservazione scientifica e
rilevamento, dei caratteri fisionomici e contenutistici degli
ambienti ipogeici e la riorganizzazione critica e per settori di
tutti gli elementi informativi acquisiti nella prima fase, sia
attraverso le acquisizioni documentarie che con le indagini sul
campo. L'analisi si articola in quattro momenti: ragionamento
sullo stato delle conoscenze; rilevamento fotografico, grafico e
schedatura; mappatura; individuazione delle corrispondenze
idrogeologiche sulla terraferma.
La terza fase, denominata studio,
è relativa alla rielaborazione tematica dei prodotti della
conoscenza conseguiti (non ultimo con la comparazione incrociata
dei vari sottosistemi dell'indagine e dell'analisi) in vista
della formulazione del progetto finale di rivalutazione di questo
particolare tipo di bene architettonico e ambientale. Lo studio
metterà a confronto criticamente il caso di Ortigia ipogeica con
esempi analoghi selezionati per affinità tipologiche, di
destinazione o di formazione ma sempre caratterizzati dal fatto
di costituire comparti di più oggetti in qualche modo raccordati
o relazionabili, tali da costituire veri e propri "distretti
ipogeici".
Arch. Ettore Sessa
Risulta sicuramente di interesse, al fine del progetto di
studio in trattazione, fornire le principali informazioni in
ordine alla cornice geologica nella quale l'isola di Ortigia è
collocata, e ciò al fine di una più corretta interpretazione
delle attività antropiche che hanno caratterizzato la sua
definitiva urbanizzazione e l'utilizzo delle sue risorse.
L'isola di Ortigia (oggi tettonicamente identificabile con un
"Horst") costituisce uno dei numerosi relitti di
terraferma risparmiati, nel corso di trascorse intense mutazioni
geologiche, dall'avanzare del mare e creato dal grande sistema
dislocativo della faglia Ibleo-Maltese lungo il margine della
Piattaforma crostale africana, che ha ribassato ad Est il fondale
del Mare Ionio, anche attraverso particolari faglie chiamate
"trascorrenti", ad Ovest tutta l'area del Porto Grande
di Siracusa e della piana alluvionale dell'Anapo-Ciane ( che oggi
costituiscono un vasto "Graben"), quest'ultima
successivamente (Quaternario) riempita da sedimenti marini e
fluviali e quindi riemersa. Il citato sistema di faglie, a
prevalente andamento NE-SW e NW-SE e subordinatamente con
direzione NS ed EW, interagisce idrogeologicamente con il ricco
sistema di falde idriche dell'Altopiano Ibleo, dando luogo,
talora attraverso complessi processi di sifonamento, a
fenomenologie sorgive, spesso di portata consistente, lungo la
fascia costiera.
Nella fattispecie l'isola di Ortigia presenta una particolare
ricchezza di acqua dolce, di provenienza iblea, che in alcuni
casi (Fonte Aretusa) viene a giorno con manifestazioni copiose
(qualche centinaio di litri al secondo), in altri è stata
captata da pozzi scavati dall'uomo nel corso della storia; è qui
il caso di citare come esempio i più conosciuti, quale il Bagno
della Regina al Castello Maniace, oggi praticamente prosciugato,
la Fonte delle Puerpere presso la Chiesa di S.Filippo, le Concerie presso la Fonte Aretusa, e così
via.
Litostratigraficamente Ortigia è costituita, nel suo settore
centro meridionale (da Corso Matteotti-Porta Marina al Castello
Maniace) dalle Calcareniti biancastre, ben stratificate ed
alternate a livelli più teneri di marne calcaree, facenti parte
della Formazione Monte Carrubba di età Tortoniano
Superiore-Messiniano Inferiore (10-15 milioni di anni), aventi
giacitura ENE, dotate in genere di basso coefficiente di
permeabilità primaria, ma discreto, talora elevato, coefficiente
di permeabilità secondaria nelle aree interessate dagli intensi
processi di fratturazione presenti lungo i principali piani di
discontinuità, piuttosto diffusi nell'isola.
Il settore settentrionale di Ortigia si presenta geologicamente
più giovane, privo di cavità ed idrogeologicamente non di
interesse ai fini del presente lavoro. La presenza di cavità
artificiali (p.es. le gallerie utilizzate durante il secondo
conflitto mondiale come rifugio antiaereo) consente di indagare
il sottosuolo di Ortigia in modo pressochè capillare, vista la
loro distribuzione.
Antonello Mamo
Planimetria di Ortigia con l'individuazione dei siti ipogei
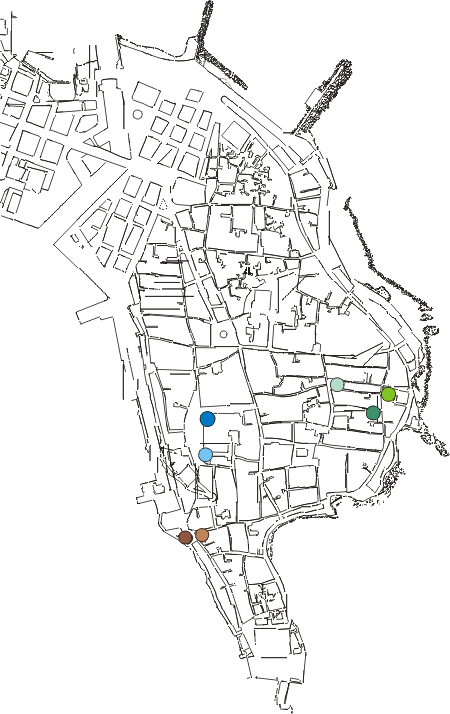 |
Legenda della Planimetria di Ortigia: Sito
I - Piazza Duomo: Sito II - La fonte Aretusa: Sito III - Il quartiere della Giudecca: |
Torna alla Home Page